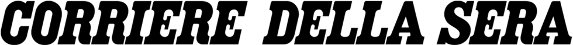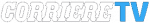
Il fact checking dei medici dell'Humanitas tra AI ed esperienza umana: ecco le risposte ai dubbi sul tumore al colon-retto

Attualità Martedì 07 Giugno 2022 ore 07:30
L'oratorio di Pontedera, una storia da tenere viva

In Via della Misericordia si giocava a calcio con la palla che si trovava, i canestri erano cerchi senza retina e poi il biliardino e il ping pong
PONTEDERA — “Se oggi volessi rigirare Accattone, non potrei più farlo” scriveva Pier Paolo Pasolini nell'ottobre del 1971 a proposito del suo film del 1961. Ed aggiungeva: “non troverei più un solo giovane che fosse nel suo 'corpo' nemmeno lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in Accattone”.
Se oggi come oggi, cento ragazzi andassero a giocare all'Oratorio, non ci entrerebbero fisicamente, a causa delle distanze di rispetto che mantengono fra di loro, per via di quello spazio privato che ciascuno vuole intorno a sé per sentirsi protetto e per parlare a proprio agio col cellulare.
E invece negli anni cinquanta e sessanta, ce ne entravano molti di più di cento, anzi, come nelle fiabe o nei sogni, ci entravano tutti quelli che ci volevano entrare. Nessuno escluso.
Appena il prete, munito di una grossa chiave di ferro, apriva il portone di Via della Misericordia, i ragazzi si slanciavano lungo un buio corridoio che a metà prendeva luce da un cortile interno, e che proseguiva fino a un'altra porta. Spalancata anche quella, saltati due gradini, si entrava nel regno dei balocchi.
A destra c'era uno scalcinato tavolo da ping pong, con una retina rattoppata e tenuta in piedi alla meglio. Le racchette d'ordinanza erano di legno compensato, fatte a mano, a volte tondeggianti a volte rettangolari. La pallina di celluloide non di rado presentava delle ammaccature, che rendevano imprevedibili le traiettorie dei rimbalzi.
I primi arrivati si disponevano intorno al rettangolo verde, e i giochi potevano cominciare.
La regola ferrea era che chi perde va fuori, mentre il vincitore restava all'infinito, passando da una partita all'altra, finché non veniva sconfitto da qualcuno più in forma, o dalla sfortuna, o perché lo assaliva la noia avendo adocchiato qualche altro passatempo.
Il pubblico, in attesa del proprio turno, faceva da arbitro con la giustizia della democrazia diretta e immediata, in maniera lontana mille miglia dalla saccenteria tediosa e snervante della moviola televisiva.
Poteva succedere di passare un pomeriggio intero prima di fare una partita, perciò era tale la foga di chi impugnava la racchetta, che non era possibile giocare per puro divertimento, e lo spirito di un agonismo forsennato dominava chiunque. Così che quando sono diventai grande, se mi capitava di fare qualche partitella con chi non veniva dalla scuola dell'Oratorio, a parità di bravura, risultavo sempre vincitore, perché mi era entrata nel sangue una notevole forza gladiatoria, unita a mille astuzie tecniche.
Proprio davanti a quel tavolo da ping - pong, che rappresentava l'oggetto del desiderio di chi si struggeva dalla voglia di giocare, a due metri di distanza, c'era un altro tavolo, bellissimo, con la retina tirata alla perfezione, il piano senza scheggiature e graffi, la linea bianca di divisione del campo ben visibile, le zampe di sostegno ben allineate alla stessa altezza.
Eppure fino a metà pomeriggio, non solo nessuno avrebbe mai osato giocarci, ma tutti si mantenevano a una distanza di sicurezza, senza avvicinarcisi troppo. Mai e poi mai che un ragazzo prendesse per il collo un altro più debole e gli facesse sbattere la testa sopra quel tavolo, come invece poteva succedere in qualunque altro luogo dell'Oratorio, dato che la violenza faceva parte della socializzazione giovanile.
Ma alle cinque e un quarto della sera, puntualmente ogni giorno arrivava colui che per due ore di seguito avrebbe usato il tavolo bello. Era 'il Galli', campione italiano di quella specialità. Arrivava con il volto sorridente e con in dosso la tuta blu degli operai della Piaggio. Si cambiava mettendosi i pantaloncini e la maglietta a mezze maniche, faceva un po' di riscaldamento, poi sceglieva il più bravo dei ragazzi presenti e cominciava ad allenarsi con lui.
Il suo era un gioco molto spettacolare. Usava racchette 'giapponesi' di caucciù, che davano ai colpi un suono intenso. Egli faceva continue schiacciate, stava molto distante dal tavolo, pronto a balzare in avanti per rispondere alle palline sotto rete.
Ho ancora negli orecchi il rumore delle sue scarpe, quando battevano a terra dopo un balzo felino.
All'opposto di tutti noi, lui giocava per giocare, senza contare i punti. Qualche volta per acquisire un ritmo da competizione, organizzava dei tornei, ed offriva fino a venti punti di vantaggio ai suoi avversari. Per esercitarsi nei tiri di precisione piazzava una moneta sul tavolo, cercando di colpirla manovrando di dritto o di rovescio.
Mauro Galli era molto educato, di buone maniere, non si vantava, non scherniva nessuno, parlava con pacatezza e con toni sommessi; era proprio un campione!
Al di là dei tavoli da ping – pong, piazzato accanto a un finestrone, c'era quello che viene chiamato calciobalilla, ma che allora veniva indicato col nome di biliardino.
Era un biliardino piuttosto basso, le sagome dei calciatori non erano a tutto tondo come quelle di oggi, ma piatte e a due dimensioni: altezza e larghezza.
Le stecche impugnate dai giocatori erano semplici manici di scopa, le porte erano due scatoline di compensato imbullettate dietro le spalle del portiere, e quando la pallina andava dentro per un gol, si recuperava con la mano. Le partite duravano fino a sei, e anche lì vigeva la dura lex del 'chi perde va fuori”.
Dopo lo stanzone dei giochi da tavolo, attraverso due porte a vetro, si poteva accedere a una specie di corridoio all'aperto, delimitato da delle ringhiere di ferro e da dei pini, sotto i quali, seduti a dei tavoli, alcuni si divertivano con le carte, sotto gli sguardi di molti curiosi che assistevano alle briscole, alle scope, ai trecento e ai tressette.
Dopo i pini c'era il mitico campo di pallacanestro. Tabelloni di legno, cerchi senza nemmeno un brandello di retina, pavimentazione in cemento che sovente si sfaldava e si avvallava, falsando i rimbalzi della palla e formando pozzanghere alle prime piogge. Eppure sembrava anche troppo perfetto, pareva che non gli mancasse niente e che ogni cosa fosse come doveva essere. Io avevo la sensazione che perfino l'aria che si respirava lì, fosse l'aria della pallacanestro.
D'altronde questa sensazione era avvalorata dalla presenza concreta di una straordinari squadra di basket che si era costituita misteriosamente, sulla base di fortunate coincidenze: quando e in che modo fosse nata nessuno lo sapeva.
Artefice di questa alchimia fu senz'altro il dottor Zoli, che era un medico della Piaggio.
Costui era un vero personaggio, schivo, riservato, sempre col cappello, si spostava per la città su una grande bicicletta nera. Apparteneva a un'altra epoca. L'inverno indossava un lungo loden verde. Faceva il presidente della squadra che si chiamava Juventus, con grande signorilità, senza mai far trasparire nelle parole e negli atti la sua passione, che doveva essere travolgente. Durante le partite il dottor Zoli sedeva al tavolo della giuria con il compito di azionare un grande orologio tenendo, con imparzialità assoluta, il computo delle pause di gioco. Era lui a suonare una trombetta per decretare la fine della partita!
A quei tempi la pallacanestro dell'Oratorio era creata giorno per giorno, con una invenzione continua dei gesti tecnici che nascevano come se fosse la prima volta che si manifestavano. Non esisteva infatti l'informazione visiva della televisione, nessuno conosceva l'evoluzione tecnica di quella disciplina sportiva nel mondo.
Unico contatto con il basket di alto livello, furono alcune partite amichevoli con la squadra americana di Camp Darby di Tirrenia. Quei giocatori dalla pelle bianca o nera, fecero molta impressione a Pontedera, come quando lo zingaro Melquiades mostrava le sue straordinarie invenzioni alla gente di Macondo, nel romanzo Cent'anni di solitudine.di Garcia Màrquez.
Perciò alcuni giocatori non si vergognavano di niente, nemmeno a tirare i personali allargando e piegando le gambe, mentre tenevano la palla all'altezza delle ginocchia, e la dondolavano due o tre volte prima di lanciarla a colombella verso il cerchio di ferro.
Il giocatore più carismatico (un vero idolo), realizzava punti su punti facendo partire i tiri in maniera non certo ortodossa, in quanto, inarcatosi in dietro come un giunco, faceva partire la palla sopra la testa a mo' di catapulta.
Lui si chiamava Pierino ed era amatissimo dal pubblico che si beava a seguire le sue giocate sempre inaspettate e straordinarie. Ogni volta che aveva la palla, l'attenzione era massima, come se dovesse succedere chissà che cosa. Faceva dei sottomani che duravano un'eternità, ruotando i bracci come un'elica due, tre, quattro volte.
Si stava tutti ad ammiralo e, caso unico nella storia sportiva di Pontedera, anche se falliva il punto, era applaudito ugualmente.
Egli non aveva il fisico del campione, era piuttosto magro, non alto, le gambe un po' storte simili a quelle di un caw boy, un carnato bianco sporco come l'avorio. Ma il suo carattere era tutto pepe. Egli era sempre in partita, e anche quando faceva una semplice rimessa laterale, dava al suo gesto grande solennità, Aveva lo stesso modo di comportarsi di un grande giocatore di quei tempi che si chiamava Omar Sivori.
Pierino si allenava raramente, era taciturno e appariva spesso melanconico, quasi tormentato, come James Dean del film Gioventù bruciata.
Una volta osò perfino allungare un ceffone al padre spirituale dell'Oratorio che era don Bertelli, e fu allontanato per un anno dalla squadra. Ma quando tornò in campo, nonostante la lunga inattività, era meglio di prima. Nella prima partita dopo la lunga assenza, a un certo punto rubò palla e si lanciò in contropiede, ma al momento del tiro, trovandosi chiuso da un difensore avversario, lo beffò con una mossa rocambolesca che non si era mai vista a Pontedera: passò la sfera a un suo compagno da dietro la schiena! Oggi questo è un movimento tecnico normalissimo, usato ad ogni piè sospinto, ma allora tutti quanti pensarono che Pierino l'avesse inventato ex novo, e che nessuno sarebbe mai riuscito a imitarlo.
Quel passaggio fu inaspettato per tutti, anche per il Volpi che si impappinò e, solo sotto canestro, sbagliò clamorosamente il tiro. Da allora fu soprannominato per sempre Pisolo.
Pierino incarnava l'aggressività dei tifosi pontederesi, ne era il simbolo, la manifestava appieno.
Pierino era il beniamino di tutti, perfino Romano (un handicappato magro come una sardina, ma beffardamente chiamato Cavicchi in riferimento a un noto peso massimo della boxe), a dispetto della sua balbuzie e delle sue turbe mentali, di fronte alle gesta di Pierino, dava libero sfogo ai propri sentimenti.
Cavicchi aveva un ruolo ufficiale, perché faceva il segnapunti manovrando dei rettangoloni di legno, con le cifre stampate a caratteri ben vistosi, da appendere a un chiodo su una bacheca. L'antesignano del tabellone elettronico!
Solo una volta Romano osò contraddire le indicazioni degli arbitri che non avevano voluto convalidare un sacrosanto canestro al Ciappi.
Il Ciappi, laureato in legge, era l'unico intellettuale della squadra formata per il resto da operai della Piaggio. Egli giocava da Pivot, stando sempre con le spalle al canestro, mimetizzato in mezzo agli avversari. Giocava d'astuzia e come poteva, sfoderava un magnifico uncino.
L'uncino era la sua arma preferita, sembrava lo avesse inventato lui da quanto gli veniva naturale e lo usava da ogno posizione. Perciò nessuno si sarebbe scandalizzato se avesse tirato i personali col 'gancio', perché quella era un'epoca di assoluta libertà sportiva.
Il Ciappi fu l'unico giocatore ad avere una richiesta d'acquisto. Lo ingaggiò il Montecatini pagando in natura con scarpe da tennis e tute da ginnastica.
Il suo posto fu preso da Paolo Mannari che determinò un cambiamento sostanziale nella squadra, trascinandola a competere con qualsiasi avversario senza mai sfigurare.
Mannari fu il primo ad avere un aspetto fisico adeguato al gioco del basket. Alto, magro, forte nei contrasti, veloce, elegante, giocava Pivot ma non disdegnavo di tirare da fuori area. Introdusse un'aggressività di tipo agonistico, rinunciando alle intemperanze gratuite, alle smargiassate, ai colpi plateali a cui molti suoi compagni non sapevano rinunciare.
Ma soprattutto il Mannari, quando saltava, riusciva a restare con la palla in mano fermo a mezz'aria, per un tempo infinito, come se fosse stato legato a uno spago. Era impressionante la sua capacità di contravvenire alle leggi della gravitazione universale. A volte si aiutava con lo slancio della corsa, oppure con un maestoso movimento rotatorio delle braccia. Ma sovente si librava in alto di punto in bianco, come il Genio della lampada magica di Aladino. Solo i suoi occhi intelligenti si muovevano alla ricerca di un compagno da 'servire'.
Un'impressione simile me la fece Pelé quando lo vidi giocare in una partita amichevole, allo stadio di Campo di Marte con la Fiorentina.
Il pallone era stato crossato all'altezza del punto da cui vengono calciati i rigori. Saltarono in tre, due difensori e l'attaccante Pelé. Salirono insieme in aria per un po', finché i calciatori gigliati, raggiunta la loro quota massima di ascensione, si fermarono, restarono un millesimo di secondo fermi, per poi ricadere verso il basso. Pelé invece continuava a salire, e saliva ormai completamente solo verso il cielo infinito. Tutto il pubblico era ammutolito ed aveva gli occhi incollati sulla sua eterea figura. A un certo puntò lui si fermò e colpì di testa la palla. Fu una botta secca che, nel silenzio generale tutti udirono nitidamente. La sfera di cuoio cambiò improvvisamente traiettoria e andò a stamparsi sulla traversa. Vedere per credere!
Un altro volo per me indimenticabile, avvenne durante una partita all'Oratorio contro una squadra dell'imbattibile Livorno. Erano gli ultimi due secondi di gioco e la Juve-Pontedera si trovava sotto di un punto. Sulla rimessa laterale, per un fallo tattico degli avversari, ebbe la palla Riccardo Nassi. In quel frangente era la persona giusta, essendo egli capace di mantenere una calma olimpica, senza mai farsi coinvolgere dalla frenesia del gioco.
Il Nassi appariva sempre e comunque tranquillo, con stampato sul volto quel sorriso ineffabileche lo scrittore Rudolf Borchardt descrive nelle figure del grande scultore medievale Giovanni Pisano. Essendo un operaio della Piaggio, dove vigevano le tecniche tayloristiche, con i tempi di lavoro della catena di montaggio misurati al centesimo dai cronometristi, egli seppe utilizzare appieno quei preziosi secondi. Con un balzo si avvicinò all'area degli avversari e mentre gli arbitri, col fischio in bocca, gonfiavano le gote per porre fine alla gara, scagliò in alto, verso il canestro, la palla. Il tempo era scaduto ma, per regolamento, finché la traiettoria prosegue sopra la linea immaginaria che unisce i due canestri, l'azione resta valida. Allora dalla mischia uscì l'unico che aveva il brevetto di volo, cioè il Melotti che era ufficiale dell'aeronautica a Pisa. Egli volò per davvero, come non avrebbe più volato così bene in vita sua, sfiorò appena la palla col polso della mano e segnò i due punti della vittoria.
Quell'anno aveva iniziato ad allenare Paolo Salcioli il quale diventò rosso rosso dall'emozione. Egli fu il primo allenatore a Pontedera che cercò di applicare schemi moderni ad una squadra che era nata manovrando di istinto e di invenzioni.
La presenza di Salcioli coincise con l'arrivo di una nuova leva di giocatori meno operai (erano quasi tutti studenti), e di ceto sociale più elevato.
Grazie a questo innalzamento culturale della squadra, ebbero spazio atleti come Alberto Pieracci, Luigi Taliani, Mario Boschi, che seppero sostituire all'immediatezza delle trovate tecniche degli albori, l'uso degli schemi tattici.
Merito del Salcioli fu quello di non creare una frattura in questo cambiamento di mentalità dei giocatori, perché egli sapeva apprezzare gli uni e gli altri.
Ricordo che una sera d'estate, durante un torneo notturno fra i bar ( La Posta, l'Excelsior, il Casarosa, il Marinai ), fece una breve apparizione Pierino, che aveva ormai abbandonato da molto tempo l'attività agonistica. Fu un vero amarcord.
Ebbene, a un certo punto Pierino entrò in area a grandi falcate, poi fintò un passaggio facendo 'gozzare' mezza difesa avversaria, e poi si lasciò andare a un sottomano meraviglioso che lo portò quasi fuori campo, da dove, con una mossa a sorpresa, cambiando direzione alla sua traiettoria, piegandosi su sé stesso e spostando il baricentro, tornò indietro volando come un boomerang. Fece allora girare la palla che prese una strana traiettoria, e finì dentro il canestro.
Fu il canto del cigno del giocatore più amato, l'ultimo regalo ai suoi fans, e il Salcioli che era accanto a me gli sussurrò: «Sei il migliore!».
Quando si studiano i primi filosofi greci, si ha quasi l'impressione che basti elencarli in ordine cronologico, per dare un'idea di quale po' po' di sapienza rappresentino.
Si comincia con Talete di Mileto, e poi via via Eraclito l'Oscuro, Anassimandro l'Antico, Anassimene, Pitagora, Parmenide di Elea, Gorgia di Lentini, Socrate.
Altrettanto significativi sono i soprannomi dei primi giocatori dell'Oratorio. C'era Mou, c'era Becio, c'era La Maiala, c'era Pisolo, c'era Blizze.
Blizze era basso, grassottello, con una faccia dura e un'espressione decisa alla Jean Gabin. Tirava 'piazzato' con molta calma, sembrava un killer, un cecchino. Difficilmente un difensore avversario osava infastidirlo, quasi avessero tutti paura a mettergli le mani 'sul muso'.
Mou era agile e scanzonato come l'attore Jean Paul Belmondo.
Le partite si svolgevano la domenica mattina alle dieci. Si faceva il biglietto al botteghino che era posto sulla destra dell'ingresso. Nell'intervallo si poteva acquistare le seme, la gazzosa, la cedrata Tassoni, il tamarindo o la spuma, in un bar situato a breve distanza, su via Della Misericordia,
Il pubblico era composto da una sessantina di persone, sedute comodamente su due gradini di cemento ai lati del campo.
Cominciai a seguire le partite su invito del mio amato maestro Ferretti, insieme ad altri compagni di classe che poi sono diventati valenti giocatori come Claudio Marconcini.
Naturalmente, come succedeva allora per tutte le cose del mondo, nessuno mi spiegò nulla delle regole del gioco che imparai da solo a forza di guardare.
Il pubblico era come se giocasse lui stesso, perché allora non c'erano gli inflessibili schemi tattici preparati segretamente dall'allenatore, e ogni suggerimento dagli spalti era ascoltato: Passa a Tizio, lascia a Sempronio, tira ora, attento a destra. Quando il quintetto partiva, era come se andasse all'arrembaggio e tutti partecipavano all'avventura: la partita era un happening, un fatto sociale, ognuno poteva dire la sua.
Nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, spesso qualcuno riusciva a impossessarsi di un pallone, e allora ci si metteva in una decina sotto il canestro. Era un gruppo molto assortito, fatto di bambini, ragazzi e giovanotti, tutti appassionatamente intenti alla caccia di un 'rimbalzo', per poter fare un tiro.
Nonostante il manto di cemento, infido come la carta vetrata, nessuno si è mai fatto male a giocare all'Oratorio. E anche quando l'attività agonistica fu spostata in una palestra al chiuso, dove l'impiantito di linoleum diventava molto scivoloso quando c'era umidità nell'aria, nessuno uscì mai di lì con una costola rotta. E questo perché il divertimento di giocare era un vero toccasana, ben più efficace delle norme di legge oggi vigenti per evitare gli incidenti.
Negli ultimi anni delle partite all'Oratorio emerse, per la sua spiccata personalità di giocoliere, Alberto Pieracci. Era un play maker che faceva girare la squadra con le sue giocate sorprendenti.
Il Pieracci era piccolino, ma con le sue doti di fantasista, e con la precisione dei suoi tiri dalla lunga distanza, seppe affermarsi alla grande. Rappresentò, simbolicamente, l'ultimo disperato tentativo di salvaguardare il carattere ludico del basket, che ha finito per essere troppo condizionato dal gigantismo di atleti di stazza fuori del comune.
Ma accanto al Pieracci, che impersonava il desiderio di mantenere il basket nel suo tradizionale alveo di disciplina alla portata di tutti, si affiancò il prototipo di un nuovo modo di concepire questo sport. Venne infatti dal Villaggio Piaggio a giocare all'Oratorio Livio Rossi, il quale, senza che nessuno gli avesse mai detto niente, cominciò a tirare sempre e comunque 'in sospensione'. Il gioco moderno, veloce, spettacolare, maschio, senza tempi morti, faceva il suo ingresso nel vecchio campo di via Della Misericordia.
Addio vecchi tiri piazzati di quando, come nella celebrazione di un rito, Blizze prendeva la palla, faceva un passo laterale, riavvicinava l'altro piede mantenendolo parallelo al primo, piegava leggermente le ginocchia, roteava i bracci uno o due volte per darsi slancio, e poi faceva partire una parabola che tutti avevano il tempo di seguire nella sua sonnolenta traiettoria. Alla fine la palla colpiva sonoramente il tabellone di legno e andava di rimbalzo nel cerchio di ferro. Si concludeva l'epoca di quando all'Oratorio nessuno tentava mai di fare una schiacciata, non solo perché tutti pensavano che il Regolamento non consentisse una tale rivoluzione copernicana, ma soprattutto perché non dava soddisfazione fare i punti mirando dall'alto in basso. Gli anni Cinquanta stavano finendo, per dare inizio a quelli del lustro successivo. In quell'epoca agli Italiani piaceva stare in basso e mirare in alto. Senza schiacciare niente e nessuno.
Intorno alla prima squadra che costituiva un'entità a sé, e che splendeva di luce propria, gravitavano decine di appassionati di tutte le età, che assistevano agli allenamenti e che, quando il campo era libero, si avventavano come lupi famelici sulla palla giocando senza risparmio di energie per ore e ore: con le scarpe di cuoio, con le suola a carrarmato, con le ciabatte o scalzi.
Si usava il pallone che c'era, da calcio, da pallavolo, raramente da pallacanestro. A secondo del numero dei presenti, si faceva il due contro due, il tre contro tre, perfino il sei contro sei. Quando pioveva erano dolori, perché le pozzanghere mettevano a dura prova l'arte del palleggio.
In queste partitelle giocavano tutti, chi sapeva e chi non sapeva, i predisposti e i negati, i longilinei e i bassotti, gli intelligenti e quelli duri come le pine verdi, i bravi e i brodi. Gli azzardi tecnici più incredibili erano consentiti.
Da questo coacervo di esperienze nacque una squadra giovanile che fu allenata da un omone chiamato da tutti Zibo. Più che i ragazzi meglio dotati, ci giocavano i più svegli, i più malandrini, che sopperivano alle carenze tecniche con un'aggressività esagerata. Mai nessuno di loro raggiunse gli onori di passare alla prima squadra.
Dunque non costituirono neppure un vivaio, rappresentarono solo un episodio estemporaneo, che si concluse per esaurimento. Ad un tratto, quasi all'unisono, i giocatori di Zibo, attaccarono le scarpe al chiodo e non si videro più.
Giuseppe Cecconi
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI