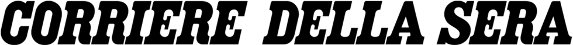Trekking urbano
di Marco Celati - Mercoledì 13 Febbraio 2019 ore 07:00

Siamo andati a fare il consueto trekking urbano la sera, per le strade, tra le luci della città. Si passa tra piste ciclabili e pedonali insidiate dal traffico, facendo lo slalom tra le auto parcheggiate. Fa un freddo becco, freddissimo. Il Paese è per metà gelato, l’altra metà inaridito, sempre incasinato è. Non sono attrezzato, mi vesto a strati: sono un multistrato vivente di maglie della salute, o almeno si spera, e felpe. E sopra, un pile di derivazione plastica, sprizzante elettricità, provvisto di cappuccio. Addosso ho una calzamaglia, quella che si prese l’unica volta che si andò a sciare, un secolo fa. Che poi io non scio, ma resto a guardare la neve, come i bambini. Calzettoni di spugna blu e pantaloni neri di una tuta scompagnata. Scarpe da jogging un po’ sformate, le migliori per i miei piedi dolci.
I soliti cinque chilometri intorno alla città. S’incontrano persone intabarrate nei loro parka coi cappucci impellicciati, ragazzi di colore, la signora indaffarata con le buste della spesa. Si incrociano i passeggeri della Stazione, quelli del treno della sera e, lungo il viale della Fabbrica, gli ultimi piaggisti. Vanno di fretta, come ombre furtive, i respiri dei fiati sono nuvole nell’aria che taglia la faccia, sbuffi condensati. Anche noi andiamo veloci. Silenziosi nel rumore della città. Tutte le città hanno una loro voce di fondo, un lamento misterioso di suoni gutturali diversi, all’origine della musica, come il canto delle balene. Ora è una sirena, quella di un’ambulanza, che grida nel buio. Un’altra anni fa, con intonazione diversa, richiamava gli operai, scandiva il tempo del lavoro. Nel sottopasso deserto della ferrovia, il murales di una bimba, enigmatico, ci guarda. La compagna in una foto la immortala. Ha una smorfia buffa sul viso, sta fischiando. La bambina, s’intende.
Torno a casa in un bagno di sudore, mi svesto e mi butto sotto la doccia. La miscelazione dell’acqua calda e fredda è sempre stato un sogno irrealizzabile, come la felicità: a volte sembra di raggiungerla e subito si perde. E così tutto avvampa e si raffredda come un amore giovane. Mi lascio torturare dal getto a bollore e mi cospargo di bagno schiuma alle bacche di ginepro nero, regalo di mio fratello. Dopo un quarto d’ora esco lessato, al vapore, dai fumi della doccia che so di ginepro e di cinghiale in umido, pronto per le olive nere e la fricassea. Resto come uno scemo seminudo nell’accappatoio blu a scrivere queste scemenze. Appunto.
Non ho avuto voglia di fare la spesa, un tè con latte e pane imburrato andrà benissimo per cena. Leggero. All’inglese. È finito anche il caffè, ho ordinato le cialde su Amazon, in offerta speciale, arrivano subito domani. Consegna a domicilio. Al giorno d’oggi potresti organizzarti in rete per stare in relazione con tutti senza vedere nessuno e senza uscire mai. Una sorta di “hikikomori”, quelli che si riducono ad una reclusione volontaria. Se ne stanno in disparte, chiusi in una camera della cui confusione non provano vergogna, come per sé o per il mondo. E non escono più di casa. Quasi monaci asceti o suore di clausura. Magari loro sono giovani, giapponesi e non, e io per fortuna sono vecchio. Un “hikikomori” da pensionati. Forse stiamo diventando tutti quanti una società asociale. Alone together. “La città mi ha insegnato infinite paure:/ una folla, una strada mi han fatto tremare”. Perché alla fine pesano il confronto, la prestazione, il rapporto, perfino il saluto. E anche i giapponesi, diciamo la verità, non sono tutta questa simpatia.
Allora mi sparo due film piratati in tivvù. Con il Chromecast che mi hanno regalato i figli, non c’è nemmeno bisogno della flebo televisiva del cavo hdmi, perché il tablet diventa un telecomando. Una vera comodità per noi poltronauti. Mi addormento per la metà iniziale del primo film e per quella finale del secondo. Non ne ricavo granché, però erano tutti e due di argomento fantasy mitologico, uno sugli dei d’Egitto, l’altro su quelli della Grecia, qualcosa alla fine resta.
Per tornare allo stato di laicità, scorro un articolo su Norberto Bobbio, nel quindicinale della scomparsa: è sempre meglio della migliore delle dittature, la peggiore delle democrazie di cui i neo millenaristi annunciano troppo in fretta la fine. Per non parlare dei neo fascisti. Penso che, in effetti, siamo in un’epoca senza più illusioni e in un mondo senza più regole. Senza passato né futuro. E fra questa disillusione e sregolatezza ci deve essere un rapporto con quello che succede nell’eterno presente.
Dall’angolo affollato dei disillusi, leggo un messaggio sul cellulare di un operaio che mi critica da sinistra gli errori della sinistra, che non è una novità, e che dice se alle elezioni si va al ballottaggio tra Centrosinistra e Lega o Cinquestelle, mi astengo. Che anche questa, purtroppo, non è più una novità. Continuiamo così, facciamoci del male, diceva Nanni Moretti. Ma era per chi non gli piace la Sachertorte, quella viennese con il cioccolato. Che, a dire la verità, non piace neanche a me. Mi stucca.
Poi viene freddo, la notte era già scesa e non resta che il sonno. Per andargli incontro, mi corico di fianco, in posizione di rincorsa. Sempre trekking è. Chissà se è meglio affidarsi ai sogni o confidare in una notte oscura e breve.
Marco Celati
Pontedera, Gennaio 2019
_____________________
“La città mi ha insegnato infinite paure: /una folla, una strada mi han fatto tremare,/ un pensiero talvolta, spiato su un viso./ Sento ancora negli occhi la luce beffarda/ dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccío”. Cesare Pavese, “I mari dei Sud” da “Lavorare stanca”.
Marco Celati